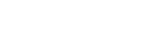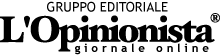L’aria del mattino contribuisce alla ripresa e anche se mi impongo di andare a letto una volta arrivata a casa, il disordine lasciato dai miei figli mi dà la botta finale e il risveglio è totale, come se avessi dormito ore e ore. Tutto va bene se il giorno dopo sono di riposo ma se devo fare l’altro turno di notte è tragico, cerco di riposare nel pomeriggio, anche se sobbalzo ogni tanto per l’eccessivo rumore che fanno i bambini. I miei pensieri vengono distolti dal suono del campanello e sorrido nel vedere illuminato il numero della camera 12 occupata dalla signora Maria, una dolce e bisbetica vecchietta… Sapevo che prima o poi mi avrebbe chiamata.
Con la scusa di un dolore immaginario mi vuole per chiacchierare, io l’accontento sempre, dopo tutto cosa mi costa e poi mi fa piacere esserle di aiuto, sapere che dopo una breve conversazione si addormenta tranquillamente.
– Buonasera signora Maria, come ha passato la giornata?
– È venuto mio figlio -mi dice sorridendo-
– Bene, sarà certamente contenta
– Per niente -dice assumendo la sua caratteristica espressione da vecchietta bisbetica- è venuto con mia nuora. Pensa mi ha salutata appena, sembrava stesse facendo uno sforzo enorme a rimanere qui.
– Forse è stata solo una sua impressione, perché non cerca di vedere il lato positivo? È venuta e questo dovrebbe rallegrarla.
– Per niente! È antipatica, si crede la principessina sul pisello, deve ringraziare Dio di aver trovato un marito come mio figlio, cosa che non faccio io perché avrei voluto un’altra moglie per lui.
– Mia cara signora, spesso quello che vogliamo noi è diverso da quello che vogliono gli altri. Sicuramente in quella ragazza suo figlio ha trovato delle doti che lei non vede, pensi solo che sono felici insieme e poi non mi ha detto lei stessa che è molto indaffarata per i preparativi del matrimonio di suo nipote?
Ed ecco che al ricordo di questo evento il viso della signora Maria si rasserena di nuovo: lei adora suo nipote.
– Ora cerchi di riposare, deve riprendere tutte le forze perché il giorno del matrimonio dovrà essere in forma.
-Speriamo -risponde lei- sono un po’ preoccupata per il vestito, sicuramente mi andrà largo, sono dimagrita tanto, io non capisco perché averlo voluto comprare eccessivamente in anticipo.
Chiaramente il rimprovero è rivolto alla nuora, ma faccio finta di niente per evitare di riaprire il discorso, poi le do la buonanotte ed esco, spegnendo la luce e socchiudendo la porta. Sorrido, so che ora si addormenterà, tanta era la voglia di raccontarmi che era arrivato il figlio che non si è lamentata dei dolori e non mi ha chiesto niente per alleviarli.
Faccio il giro delle camere, controllo se tutto è a posto e ritorno in medicheria. Il collega che fa lo stesso turno con me è nell’altra camera e vede la televisione, mentre io cerco di dare una riordinata ai carrelli della terapia. Ben presto cambierò reparto, ho vinto il concorso da caposala e svolgerò questo nuovo ruolo in un reparto di lunga degenza. Ne sono contenta e non vedo l’ora che passino questi giorni, un po’ perché finalmente avrò dei turni più regolari, e poi perché potrò finalmente cambiare alcune cose che a mio avviso non vanno bene. Sono sicura che ne avrò sia le competenze che le capacità giuste. E poi ho l’appoggio del capo personale che è d’accordo su come intendo gestire il reparto, del resto è stata discussione di tesi in sede di esame e credo siano state le mie idee innovative a farmi vincere a pieni voti il concorso.
Sono dieci anni che lavoro come infermiera e ho cercato sempre di migliorarmi. Credo in quello che faccio, ma soprattutto credo che non sia un lavoro che si possa improvvisare. Sei spesso portata ad affrontare turni estenuanti, situazioni delicate dove devi cercare di tenere a bada la tua emotività dando spazio solo alla tua professionalità. E’ un lavoro che devi sentire dentro, in quanto oltre alla tecnica devi avere la capacità di comprensione empatica che certamente non ti puoi inventare. La devi avere dentro. Ecco il motivo che mi porta spesso a non essere d’accordo su alcuni comportamenti superficiali di colleghi che non so per quale strana magia sono riusciti a prendere il diploma di infermieri.
Come sono arrivata a capire che volevo fare l’infermiera? Non sempre la scelta avviene perché hai un esempio da seguire, perché vieni consigliata dai tuoi genitori o perché è la tua unica alternativa di lavoro. No, non sempre è così. A volte ci arrivi per esperienza diretta, a seguito di una sofferenza profonda che ti porta a capire chi sei e cosa credi di poter essere e di poter dare. Mentre rifletto finisco di lucidare il carrello delle medicazioni, metto in ordine i farmaci e poi mi siedo in poltrona. Già, cosa mi ha spinto a diventare infermiera. Ricordo tutto come se fosse ieri. Del resto ci sono cose della tua vita che, per quanto tu voglia cancellare o chiudere in un cassetto, ritornano sempre alla mente, a volte come dei flash back, come a ricordarti la dura battaglia affrontata, come a ricordarti di non arrenderti mai…
Non ricordo di essere mai stata una bambina spensierata e serena. Fin da piccola soffrivo per il mancato rapporto con i miei genitori, per il loro egoismo e la loro poca attenzione ai miei bisogni, soprattutto affettivi. Giocavo sempre con mio fratello e i suoi amichetti e per questo ero definita da mia nonna, che viveva con noi, “un maschiaccio”. Lei adorava mia sorella, di cinque anni più piccola di me, tollerava mio fratello, non sopportava per niente me. Venivo continuamente punita ed oggi posso dire che lo faceva anche per stupidaggini. La sua punizione preferita era quella di chiudermi in uno stanzino, dopo avermi picchiata con un cucchiaio di legno.
Mia madre era sempre al lavoro con mio padre e mi mancava tantissimo. Negli anni, poi, ho capito che la sua scelta di vita non è stata per un’esigenza di lavoro, ma per una sua incapacità ad assumere il ruolo di mamma. E’ stato molto più facile seguire come un’ombra mio padre, accudendolo come un bambino, il suo unico bambino esigente e capriccioso. Mio padre: un uomo egoista ed egocentrico che ha fatto delle sue esigenze, di ogni genere, unica essenza della sua vita, avendo la capacità di sopprimere totalmente le personalità di chi avrebbe dovuto amare: i figli.
A diciannove anni, dopo numerose diete riuscite e non, con un inesistente rapporto con i miei genitori e una profonda solitudine, decisi che non era più il caso di andare avanti. Mi procurai, con una ricetta sottratta a mio padre, dieci confezioni di sonniferi. Ricordo perfettamente il giorno che le tenevo nascoste tutte nella borsa e in pullman mi dirigevo verso il posto che avevo scelto con cura per attuare il mio proposito. Ero convinta che di sera nessuno mi avrebbe trovata in quel luogo sperduto, ma non avevo fatto i conti con una coppietta che si era accorta di me nascosta tra gli scogli, addormentata per effetto dei farmaci, quasi del tutto in acqua; mancava poco che annegassi. Ricordo ancora oggi lo stato d’animo che avevo quando ero su quel pullman: ero serena, mi sentivo per la prima volta in pace. Sapevo che presto tutto sarebbe finito e questo mi dava un grande senso di sollievo. Quella morsa che mi contorceva lo stomaco era scomparsa, i continui pensieri che mi torturavano la mente avevano cessato di esistere. Ero finalmente libera.
Quando mi sono risvegliata c’è voluto un po’ per capire dove mi trovassi. Ero in rianimazione, sono stata in coma per tre giorni. Nessuno sapeva niente di me, non avevo documenti e nessuno aveva denunciato la scomparsa di una ragazza con le mie caratteristiche. I miei genitori avevano pensato che me ne fossi andata e se era quello che volevo non avevano niente da obbiettare. Io non rispondevo alle domande dei medici, della polizia, non mi interessavano, non mi interessava nessuno, pensavo solo a quello che non era successo, al perché. Mi sentivo avvolta da un alone che mi distanziava da tutti e da tutto ciò che mi circondava. L’unico che non ha mai creduto a una mia fuga è stato un amico di mio fratello che, conoscendomi, sapeva che non l’avrei mai fatto senza salutarlo. E così convinse gli altri a cercarmi.
Quando vennero i miei a prendermi in ospedale non fui felice, perché realizzai che tutto stava per ricominciare. Poi seppi da mio padre che il giorno dopo sarei andata in un posto tranquillo. Loro avevano già programmato una crociera e non potevano lasciarmi a casa da sola. A me andava bene tutto, purché lontano da loro. Ben presto mi resi conto che quello che loro chiamavano “bel posto” era un Istituto Psichiatrico. Sono stata ricoverata in un reparto che chiamavano infermeria, dove erano ricoverati i casi meno gravi, più gestibili: demenze senili, schizofrenie in trattamento, forme maniacali di vario tipo. E c’era una folle che aveva tentato il suicidio e non aveva più voglia di vivere.
Il mio arrivo fu accolto con molta curiosità: mi guardavano con insistenza, alcune mi toccavano ed altre mi facevano continuamente domande, sempre le stesse. Ero seduta a terra in veranda e non mi facevo toccare da nessuno e in quella posizione mi addormentai. Solo la suora, verso sera, riuscì a portarmi a letto. Un letto in un enorme camerone dove dormivano altre sette pazienti, o meglio non dormivano. Le notti le passavo sveglia con la paura che qualche altra paziente si avvicinasse e mi toccasse, come di solito facevano durante il giorno. Ma la luce del giorno mi dava la sensazione di riuscire a difendermi, mentre il buio della notte no, mi lasciava completamente indifesa e spaventata da ciò che non sapevo.
La suora del reparto era tanto dolce con me e la ricordo ancora con tanto affetto. Durante i pasti, avendo colto il mio disagio, mi faceva mangiare in una stanzetta adibita ai suoi lavori di cucito. Questo perché non riuscivo a mangiare insieme alle altre pazienti, in quanto alcune mangiavano con le mani e se qualcuna si arrabbiava, versava tutto sul tavolo e sputava. Insomma, non era facile accettare tutto quello che vedevo. Quando non c’era il dott. Eugenio, medico del reparto, passavo le mie interminabili giornate in veranda guardando giù in cortile. Affacciava sul reparto degli agitati ed io osservavo quelle donne e quegli uomini, divisi da una rete metallica. Se si avvicinavano tra loro, agitandosi e facendo gesti sconci, un guardiano (alias operatore) era pronto ad intervenire con una pompa, bagnandoli con acqua fredda. Spesso mi domandavo se anch’io, un giorno, sarei andata a finire in quel reparto, comportandomi come loro, se anch’io un giorno sarei stata trattata in quel modo disumano.
Il dott. Eugenio cercava di scuotermi, di farmi parlare, di farmi uscire da quel guscio nel quale mi ero rinchiusa. Con il passare delle settimane e con il suo aiuto ho iniziato piano piano a guardarmi intorno con meno diffidenza. Ho iniziato ad osservare con più interesse ciò che mi circondava. Mi ricordo di Franca, una ragazza schizofrenica, che passava quasi tutto il giorno a cantare, incitandomi continuamente a farlo con lei. E dato che innervosiva le altre pazienti, veniva continuamente messa a tacere dalle operatrici anche in malo modo. Allora si sedeva vicino a me in veranda e cantava sottovoce. C’era una donna della quale non ricordo più il nome, mi chiedeva spesso di leggerle il suo libro, porgendomi le mani vuote. Io non sapevo cosa dire e lei si arrabbiava. Quando ho imparato a non avere più paura di lei e mi chiedeva di leggere il suo libro, bastava che le dicessi qualsiasi cosa e lei andava via tutta felice.
Ed ecco il ricordo di Carolina, che sembrava una piccola monella cresciuta e faceva quello che non doveva fare, compreso spogliarsi. E poi ti guardava sorridendo, tutta felice, proprio come fanno i bambini. Fu proprio lei a farmi ridere per la prima volta. Dopo averne combinata una delle sue, l’operatrice e la suora cercavano di prenderla, ma lei si nascondeva dietro qualsiasi cosa e ridendo diceva “cucù, dove sono?” Questo trambusto fece innervosire alcune pazienti. Così Carolina, messa alle strette e non sapendo più dove nascondersi, quella volta prese la sua scarpa, se la mise davanti agli occhi e ridendo disse “cucù, dove sono?” Io iniziai a ridere fragorosamente e tutte le altre con me, compreso la suora, allentando così la tensione che si era venuta a creare.
Con il tempo ho realizzato che a loro bastava poco, una parola dolce, un sorriso, una carezza, un po’ di attenzione. Ho realizzato che non bisognava aver paura di loro, in quanto non si può avere paura di chi soffre, e che l’alternativa all’aggressione è la comprensione. Quelle persone tanto sfortunate, avevano bisogno di avere al loro fianco persone professionalmente capaci e dotate di una grande carica di umanità. Loro avevano capito che ero cambiata, si avvicinavano senza avere più il timore di spaventarmi, di disturbarmi, non mi chiedevano più scusa quando si avvicinavano. Per Franca ero diventata la sua dottoressa.
Passavo molto tempo con il dott. Eugenio, lui voleva che uscissi al più presto da lì. È stato fin dall’inizio contrario al mio ricovero, ma quando realizzò che, comunque, per me ci sarebbe stato solo un Istituto Psichiatrico, preferì tenermi con lui. Dopo quasi cinque mesi sono uscita e si sono chiusi i cancelli alle mie spalle, ma ho iniziato di nuovo ad avere tanta paura. Ormai lì mi sentivo al sicuro, protetta, tante persone credevano in me, persone diventate amiche. Come potevo ritornare in quel mondo ostile? Eppure il dott. Eugenio mi ha catapultata fuori perché era ora che affrontassi il mondo esterno, più rimanevo e più sarebbe stato difficile uscire da quel mondo che mi stava proteggendo.
I primi giorni sono stati difficilissimi e mi chiedevo perché, mi sentivo abbandonata non sapevo cosa fare. Poi ho iniziato a pensare a loro e ho capito che non mi dovevo arrendere, che il mio nuovo percorso di vita stava incominciando proprio in quel momento e che dovevo assolutamente prefiggermi un obbiettivo importante per me e per tutti quelli che avevano creduto in me. Così mi iscrissi al corso di infermiera professionale. Questa scelta, in un momento particolare della mia vita, non è stato un rifugio alla sofferenza, ma una decisione ben ponderata, un obbiettivo da raggiungere, consapevole di quello che dovevo fare e come avrei dovuto farlo.
Chiudo il cassetto dei mie ricordi e con un sospiro ed un sorriso rispondo al mio collega accettando la tazzina di caffè che mi sta offrendo.
– A cosa stavi pensando? -mi chiede- sembravi in trans, ti ho dovuto chiamare due volte, mi stavo quasi preoccupando.
Lo guardo e gli sorrido.
– A un pezzo della mia vita -gli rispondo.
– Deve essere stato qualcosa di veramente importante.
– Sì, è stato l’inizio della mia vera vita…
Guardare avanti oltre quel muro che sbarra i tuoi pensieri non è facile, dare una risposta alle tue mille domande è quasi impossibile, perché alla fine ti rendi conto che molte domande non hanno risposta. Ti rendi conto che il dolore è tuo, non è condiviso, non è capito, non è accettato. Io ho avuto la possibilità di vedere quella lucina accesa che ne ha illuminato il sentiero. Ho avuto la fortuna di vedere e sentire il calore di tante mani tese, quelle mani che di solito ci sono, ma che a volte non vediamo perché sprofondati nel nostro stesso dolore. Ecco che quelle mani tese mi sono servite per rialzarmi, uscire, camminare e accettare una realtà che solo io potevo modificare. Perché era… la mia vita.
BIOGRAFIA
Daniela Lelli è nata a Roma nel 1954. È infermiera in pensione e scrittrice. I primi 10 anni ha lavorato in terapia intensiva presso l’ospedale di Taranto e poi caposala a Milano, in una clinica privata che si occupava di Alzheimer. Il suo lavoro le ha permesso di sviluppare una sensibilità interiore e un amore particolare per la vita. Ama scrivere racconti brevi, con i quali ha vinto numerosi primi premi, ed ama scrivere a quattro mani con suo marito Cesare Natale, anche lui infermiere e scrittore poeta. Insieme hanno pubblicato due romanzi: L’amore oltre la vita e Via della felicità 8, vincendo numerosi premi. A breve pubblicheranno il terzo romanzo E il tempo sta guardare. Entrambi sono stati ospiti due volte del programma di Rai1 La vita in diretta, con Mara Venier e nell’edizione con Paola Perego, poi ospiti presso Uno Mattina Rai e in una serie, a loro dedicata, del programma di Rai3 Non ho l’età, per parlare della loro fantastica storia d’amore giovanile (si sono rivisti dopo 28 anni) e per parlare del loro impegno nel sociale, in quanto fondatori e responsabili di un’Associazione che utilizza l’aspetto culturale come mezzo di comunicazione e l’aspetto Socio Sanitario, sostenendo i malati di Alzheimer e i loro caregiver, con l’aiuto di un gruppo di amici volontari, proseguendo così, senza sosta, l’impegno sociale da paramedici.
Racconto a cura di Daniela Lelli