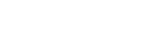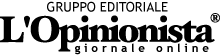Dietro il primo dipinto, Madonna con Bambino, divenuto assai celebre, e che l’autore aveva chiamato “Maternità”, c’è una storia molto toccante. Ferruzzi un giorno si fermò a guardare una bella ragazza, tale Angelina Cian, seconda di quindici figli, che teneva in braccio il fratellino di pochi mesi di nome Giovanni. Il pittore dovette essere così colpito dalla dolcezza della scena che si presentò davanti ai suoi occhi, che volle riprodurla in una tela. Il dipinto venne esposto – e premiato – alla Biennale di Venezia nel 1897. Nel corso del XX secolo l’opera è stata chiamato con diversi nomi: Madonna con bambino, Madonna del Riposo, Madonna delle Vie, Madonna della Tenerezza, e Zingarella.
Angelina, la ragazza che con la soave bellezza del suo volto aveva ispirato Roberto Ferruzzi, si sposò, e agli inizi del Novecento si trasferì col marito negli Stati Uniti d’America, come avveniva in quegli anni per molti italiani. Madre di dieci figli, alla morte prematura del marito, Angelina cadde in una forte depressione e fu internata in un manicomio, dove morì nel 1972. La povera donna era morta senza aver raccontato la sua storia. I figli finirono in orfanotrofio e una di loro, Mary, divenne suora con il nome di Suor Angela Maria. Mary, dopo un’esistenza che possiamo immaginare non facile, ancorché rischiarata dalla fede cristiana, decise di andare in Italia a trovare le vecchie zie, che vivevano a Venezia. Una delle zie le mostrò l’immagine della “Zingarella”, e… possiamo solo immaginare la gioiosa sorpresa della suora nell’apprendere che il volto di una delle madonne più famose al mondo era proprio quello di sua madre Angelina. La madre del Cielo, in qualche modo, si era sostituita a quella della terra. Sono i corto-circuiti del mistero, i colori della vita che un artista attinge alla grande tavolozza dell’amore universale.
Il grande regista Franco Zeffirelli (siamo sempre sul terreno dell’arte) raccontava con accenti di commozione una vicenda della sua infanzia, che non fu proprio felice. Egli era nato a Firenze da un rapporto “clandestino” di sua madre con un uomo sposato. Rimasto presto orfano, un giorno in cui stava giocando piuttosto animatamente con dei coetanei nei pressi del convento dei frati domenicani in piazza San Marco, si sentì apostrofare da uno dei compagni di gioco come “figlio di p…”. Il giovane Franco reagì con veemenza e la zuffa che ne seguì richiamò l’attenzione di una persona che ritirava in una stanza del convento, un signore di nome Giorgio La Pira, che di Firenze diventerà un famoso sindaco. La Pira chiese ai ragazzi perché mai si azzuffassero. Saputane la ragione dal diretto interessato, redarguì aspramente l’autore dell’insulto, e poi, preso per mano Franco, lo condusse, attraverso un lungo scalone del convento, di fronte a un’immagine della Vergine, e indicandogliela gli disse: «D’ora in poi sarà questa donna la tua mamma, e quando ti sentirai scoraggiato, quando sentirai la mancanza della mamma che ti ha messo al mondo, vieni qui, dì tutto a lei». Il futuro celebre regista non dimenticherà mai queste parole, uscite dalla bocca di un santo.

Saper contemplare il mondo con gli occhi di una bambina e guardare gli altri attraverso lo sguardo dei semplici, lo sguardo degli scemi del villaggio, quelli che nessuno considera, è fare il pieno di bellezza: è il massimo della saggezza che ci è dato di raggiungere finché calchiamo la scena del mondo. Come spesso l’arte, quando è rappresentazione fedele della vita, ci fa intuire, il dolore e bellezza si richiamano a vicenda, uniti da fili invisibili ma reali. Con essi i conti della vita non tornano, ogni calcolo razionale perde di senso: il dolore reclama la gioia, l’ingiustizia la giustizia, il finito l’infinito.
Quella donna che reca in braccio il bambino è la madre dei poveri, dei disperati, dei diseredati di tutti i tempi, dei dimenticati, degli esclusi, e sta lì a ricordarci che, finché camminiamo lungo i sentieri della vita, le gioie, piccole e grandi, hanno sempre le radici a forma di croce. È impossibile a un’anima ben disposta non associare all’idea del bello quella del bene. Essa intuisce anche che il dolore è l’altra faccia dell’amore. Il dolore, al pari della bellezza, per paradossale che possa apparire, è la migliore dimostrazione che esiste un Dio che ci attende sull’altra sponda e che ci mostrerà l’altra faccia del disegno, l’opera d’arte tutta intera. C’è da credere che la bellezza, quella vera, quella che non ama di essere posseduta, ma contemplata e vissuta, alla fine salverà il mondo.
A cura di Giuseppe Lalli